
Dalla scoperta alla consacrazione nelle linee guida moderne, la metformina continua a essere il farmaco di prima scelta per il diabete di tipo 2. Scopri storia, meccanismo d’azione, benefici e controindicazioni di uno dei farmaci antidiabetici più prescritti al mondo.
Ha più di 60 anni di vita ma, ciononostante, è ancora oggi il medicinale che le linee guida statunitensi ed europee raccomandano come terapia di prima scelta per il diabete di tipo 2.
Ma cosa rende la metformina così speciale? Come funziona, quali sono le sue origini e perché continua ad essere imprescindibile nella terapia del diabete nonostante i numerosi farmaci più recenti?
Scopriamo storia, meccanismi e benefici di questo straordinario rimedio assieme a Roberto Trevisan, Professore Associato di Endocrinologia all’ Università degli Studi di Milano Bicocca.
Fa parte della classe delle biguanidi, cioè molecole formate da due gruppi chimici chiamati "guanidina", noti per abbassare la glicemia (zucchero nel sangue). La metformina è quasi sempre il primo farmaco con cui si inizia una terapia farmacologica orale nella persona con diabete tipo 2, in combinazione con un cambiamento dello stile di vita che includa una dieta equilibrata e attività fisica moderata e regolare.
Ripercorriamo in breve le tappe principali della storia di uno dei farmaci più prescritti al mondo, che ha profondamente rivoluzionato il trattamento del diabete e migliorato significativamente la qualità della vita di milioni di persone.
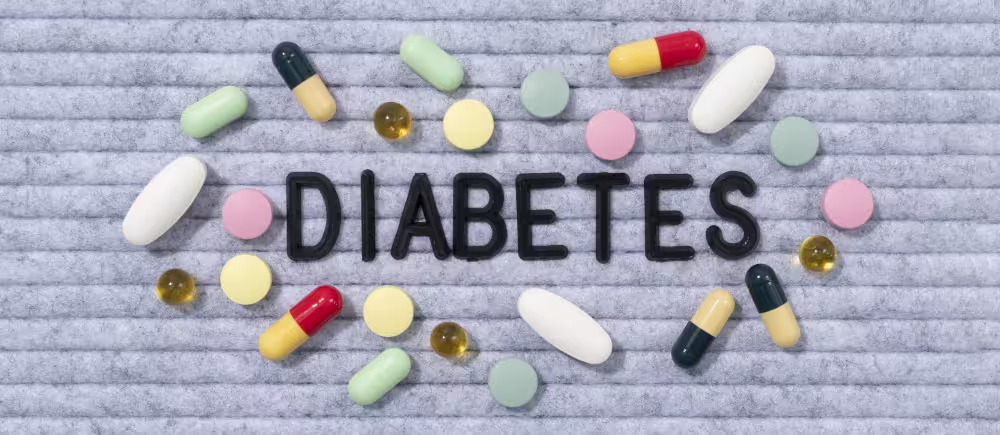
La metformina aiuta a controllare la glicemia agendo su più fronti:
Nonostante l’uso consolidato, i meccanismi cellulari alla base dei suoi numerosi effetti benefici non sono ancora del tutto chiari. Uno dei principali meccanismi antidiabetici identificati è l’inibizione del complesso mitocondriale I, che comporta una riduzione della produzione epatica di glucosio. Dopo l’assunzione orale, la metformina entra nelle cellule epatiche grazie al trasportatore OCT1 (organic cation transporter 1). Essendo una molecola a carica positiva, si accumula soprattutto nei mitocondri (organelli cellulari, spesso definiti "centrali energetiche" delle cellule), dove blocca il complesso I e attiva la proteina chinasi AMPK (AMP-activated protein kinase), un regolatore chiave del metabolismo energetico. Questo effetto porta a un miglior utilizzo del glucosio nei muscoli, alla riduzione della produzione epatica di zucchero, alla diminuzione della sintesi di grassi (lipogenesi) e all’aumento della loro degradazione (lipolisi).
A livello intestinale, la metformina riduce l’assorbimento del glucosio e promuove il trasporto del lattato verso il fegato. Si ipotizza inoltre che stimoli l’azione del GLP-1 (un ormone intestinale che regola il metabolismo glicemico) e favorisca l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule intestinali. Studi recenti suggeriscono che gli effetti extraepatici della metformina, soprattutto a livello intestinale, siano altrettanto importanti quanto quelli sul fegato. È stato osservato, ad esempio, un aumento dei livelli di GDF-15 (Growth Differentiation Factor 15), un mediatore coinvolto nel controllo dell’appetito e del peso, che contribuisce al miglioramento del profilo glicemico e alla perdita di peso.
Il tratto gastrointestinale è oggi considerato un sito d’azione cruciale: la metformina può modificare la flora intestinale e attivare AMPK anche nelle cellule intestinali, con effetti sia metabolici che ipoglicemizzanti.
Infine, la metformina mostra azioni benefiche anche oltre il metabolismo glucidico: riduce lo stress ossidativo e migliora la funzione endoteliale a livello cardiovascolare, può aumentare la sensibilità delle cellule tumorali alla chemioterapia e ha effetti regolatori sull’infiammazione del sistema nervoso, suggerendo un potenziale ruolo nei disturbi neurodegenerativi.
In sintesi, nel diabete di tipo 2, la metformina migliora il controllo glicemico senza rischio di ipoglicemia e di aumento di peso e contribuisce a lungo termine a ridurre il rischio di eventi cardiovascolari.
La metformina non è indicata nel diabete di tipo 1, perché in questa forma di diabete manca completamente l’insulina, e la metformina non può sostituirla. Tuttavia, in alcuni casi viene usata fuori indicazione (off-label), soprattutto quando chi ha il diabete di tipo 1 presenta sovrappeso o obesità. In queste situazioni, la metformina può aiutare a ridurre la quantità di insulina necessaria e a migliorare il controllo della glicemia, anche se le prove scientifiche a sostegno di questo utilizzo sono ancora limitate.
La metformina non è utile solo per trattare il diabete già conclamato, ma può avere un ruolo importante anche nella sua prevenzione. Numerose ricerche confermano infatti come, se associata a uno stile di vita sano, sia in grado di rallentare o persino impedire la trasformazione del cosiddetto “prediabete” (una condizione in cui la glicemia è alterata, ma non ancora diabetica) in diabete vero e proprio.
Un altro ambito in cui la metformina è diventata un farmaco chiave è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), un disturbo ormonale molto diffuso nelle giovani donne, caratterizzato da cicli irregolari, presenza di cisti ovariche e segni come l’eccesso di peli (irsutismo). La metformina agisce efficacemente perché riduce l’insulino-resistenza (cioè la difficoltà delle cellule a rispondere all’insulina) che spesso è la causa principale di questa sindrome, migliorando anche il quadro ormonale e alleviando i sintomi.
Negli ultimi anni, inoltre, studi epidemiologici hanno evidenziato un altro beneficio inaspettato della metformina: la capacità di ridurre il rischio di sviluppare alcuni tumori, specialmente quelli del tratto intestinale, e di migliorare la prognosi dei pazienti diabetici che ne sono affetti. Attualmente, sono in corso ulteriori studi clinici per approfondire il possibile ruolo della metformina nella prevenzione e cura del cancro.
Infine, dati preliminari provenienti da studi sugli animali e da osservazioni cliniche indicano che la metformina potrebbe avere un interessante effetto anti-invecchiamento, grazie alla sua capacità di influenzare positivamente il metabolismo e ridurre i processi infiammatori che accelerano l’invecchiamento cellulare. Progetti di ricerca come lo studio TAME ("Targeting Aging with Metformin") stanno valutando più approfonditamente queste promettenti prospettive.

Anche se la metformina può portare a una perdita di peso di 1-2 kg in media, non è un farmaco per la perdita di peso e il suo uso per questo scopo dovrebbe essere considerato solo sotto stretta supervisione medica, in presenza di condizioni come PCOS o diabete. Per perdere peso, un approccio basato su dieta equilibrata, esercizio fisico e, se necessario, farmaci specifici approvati (quali Ozempic e gLP1 agonisti) è generalmente più sicuro e molto più efficace.
La metformina è sconsigliata in caso di insufficienza renale avanzata, insufficienza cardiaca o respiratoria e/qualsiasi condizione di ipossia per il rischio di acidosi lattica. Per questo motivo si consiglia di interrompere temporaneamente la somministrazione il giorno precedente e durante l'uso di mezzi di contrasto radiografici per via endovenosa.
In Italia è consigliata la sua sospensione in gravidanza (sebbene la sicurezza d'uso sia dimostrata in diversi studi).
Per quanto riguarda i pazienti con insufficienza renale cronica si consiglia di ridurre la dose massima a 1500 mg al dì se eGFR <60 ml/min/1,73 m² e di interrompere la metformina se eGFR <30 ml/min/1,73 m². Evitare di iniziare la metformina se eGFR <45 ml/min/1,73 m2.
In fine va ricordato cha la metformina può ridurre, seppur raramente, l’assorbimento della vitamina B12, e pertanto portare a anemia macrocitica.
La metformina è unica nella sua azione e non ha alternative simili per azioni se non tollerata. I nuovi farmaci (i GLP1 agonisti e le gliflozine) sono degli ottimi sostituti (in caso di intolleranza o controindicazione all’uso della metformina) soprattutto perché entrambe le nuove classi di farmaci hanno dimostrato anche loro non solo di migliorare la glicemia ma anche di essere in grado di ridurre significativamente il rischio cardiorenale delle persone con diabete.
Marianna Monte | Giornalista
con la consulenza di
Roberto Trevisan | Professore Associato di Endocrinologia all’ Università degli Studi di Milano Bicocca